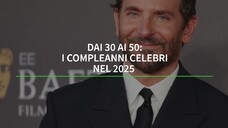Non è tanto una mera questione dell'uomo che apre la portiera della macchina alla donna o che le offre la cena: la galanteria è un fenomeno complesso e politico, legato al genere e alla storia dei femminismi, che va affrontato come un'opportunità per trasformare i rapporti interpersonali e le dinamiche di potere tra i sessi. A spiegarlo in un saggio illuminante è Jennifer Tamas nel libro "Si può ancora essere galanti?", in uscita il 7 febbraio per Marietti1820. Scritto in modo fluido e accattivante, senza alcuna pesantezza pur essendo ricco di spunti accademici e riferimenti letterari, il libro ripercorre le origini della galanteria nel XVII secolo, in una riflessione che rivela le radici storiche, culturali e politiche di questa pratica sociale fino a toccare temi di stretta attualità come il movimento #MeToo e le app di incontri oggi iperfrequentate. Il nodo principale per l'autrice, docente di Letteratura Francese dell'Ancien Régime negli Stati Uniti, alla Rutgers University (New Jersey), è dimostrare quanto la semplificazione e il dibattito da "tifoseria" che impera al giorno d'oggi siano nemici di una piena comprensione della galanteria e del suo ruolo nella società contemporanea: "Talvolta strumentalizzata per nascondere ogni sorta di fantasia, talvolta accusata di farci confondere passione e dominazione maschile, la galanteria suscita opinioni radicalmente opposte che tuttavia si riuniscono in un'idea essenziale: la letteratura continua a esercitare un potere sul nostro immaginario. Ma è paradossale attribuire tanta importanza a questa eredità culturale e poi trattarla con tanta leggerezza", scrive Tamas. Tanti gli equivoci nati attorno a questo fenomeno, ancora molto divisivo, che non è né una forma di romanticismo né di libertinaggio, usato "come deterrente o come spalla" da detrattori o sostenitori, in ogni caso spesso frainteso ma capace di portare alla luce secondo Tamas "i paradossi che ci attraversano".
Il suggerimento è quello di tornare ad analizzare le origini della galanteria, quando le donne attraverso questa pratica sociale diventano finalmente "interlocutrici" degli uomini, soggetti pensanti in grado di proporre degli scambi paritari e di scardinare l'ordine patriarcale costruendo una comunità emotiva nuova: "Anziché subire la legge prima del padre e poi del marito, le donne sfidano il silenzio imposto loro dalla morale e dal galateo, trovando nella conversazione uno spazio di libertà inedito". Dunque è sbagliato, o quanto meno semplificatorio, considerare la galanteria come un ulteriore strumento di dominazione nelle mani degli uomini, e usare contro le donne quelle "armi che hanno favorito una forma di emancipazione" come lo è stata appunto la retorica galante. La questione non è chiedersi se sia ancora possibile recuperare la galanteria (e con essa la dolcezza, la tenerezza, la raffinatezza, la conversazione come possibilità di emancipazione) o se sia retrograda, ma proporre un confronto dialettico per progredire, alla luce delle sfide contemporanee, trovando "i modi di piacersi e rispettarsi ora che abbiamo acquisito nuove libertà di amare", nuovi costumi e diritti acquisiti. La galanteria può aiutare a decostruire stereotipi, cambiare i rapporti di dominazione e rappresentare una possibile chiave per una nuova forma di civiltà relazionale: "Affinché possa nascere una nuova civiltà e cessino i falsi dibattiti si devono ripensare il regime di sguardi, il piacere nella conversazione e le opinioni informate - afferma Tamas - Veri antidoti contro l'ostilità dei social network, la disinformazione e la polarizzazione, essi potrebbero alimentare una curiosità per l'altro e ricostituire i legami umani nella loro complessità".
Riproduzione riservata © Copyright ANSA