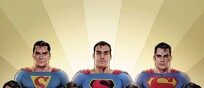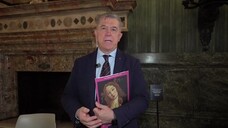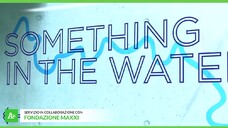(di Paolo Petroni)
John Keats, come Holderlin, come
Giacomo Leopardi e pochi altri, è proprio poeta per antonomasia,
personaggio totalmente dedito ai propri versi in cui tradurre il
proprio modo di sentire il mondo e la vita (far poesia diceva
che per lui era un ''fare anima''), che, come si consumasse
nell'intensità e ricchezza dei sentimenti, è stata quindi breve,
tanto da morire distrutto dalle emorragie della tisi a nemmeno
26 anni il 23 febbraio 1821, duecento anni fa. Una morte
avvenuta a Roma, così che il poeta romantico inglese è sepolto
nel cimitero acattolico di Porta S. Paolo e la casa dove visse,
a Piazza di Spagna, è un centro culturale intitolato a lui e a
Shelley, il cui bicentenario della scomparsa cade l'anno
prossimo.
Le due ricorrenze hanno dato vita, in Italia e in
Inghilterra, al ricco programma Keats-Shelley200. Con convegni,
incontri, borse di studio, è in programma una mostra intitolata
''Adonais'', come il poema che Shelley scrisse in morte di
Keats, anche se poi la situazione pandemica ha costretto a
cambiare tutto e trasferire molte cose online. Domani, giorno
del bicentenario, ci si potrà collegare a una serie di eventi,
dal tour virtuale della Shelley-Keats House con guida dal vivo a
quello della mostra allestita alla Keats House di Hampstead
(particolari sul sito Ksh.roma.it/news).
Nadia Fusini ha curato due anni fa, in vista della
ricorrenza, un Meridiano delle ''Opere'' di Keats (Mondadori,
pp. 212 + 1476 - 80,00 euro) e, a sottolineare l'importanza di
Keats e l'influenza che ha avuto nel mondo, ecco che esce in
italiano l'affascinante ''A passeggio con John Keats''
dell'argentino Julio Cortazar pubblicato da Fazi (pp. 672 -
20,00 euro), l'editore scrittore che ha lui stesso firmato due
romanzi biografici su Keats intitolati ''L'amore della luna''
(2005) e ''Bright Star'' (2010). Cortazar, col suo stile, chiuso
nella sua stanza a Buenos Aires, notte dopo notte scrive di
Keats, e intanto pensa, divaga, ricorda, compilando a margine
del suo libro una sorta di zibaldone, costruendo un'opera-mondo.
Di famiglia relativamente modesta, Keats, nato il 31 ottobre
1795, resta presto orfano e gli muore anche il fratello a 19
anni così, impossibilitato a frequentare l'università, prende un
diploma di chirurgo abilitato a operare sulle navi, ma non
eserciterà mai, cercando di sopravvivere con i pochi soldi
lasciatigli dalla madre e gli anticipi che riesce a avere dagli
editori. Apparentemente diversa nell'evoluzione del giovane
poeta la sua pur ricca produzione, che va dalle iniziale
influenze di Byron e Wordsworth ai suoi primi e personali
''Poemi'', alla composizione di un poema di quattromila versi
nato da una sfida con Shelley, ''Endymion'', cui segue
''Hyperion'', sino ad arrivare alla grande intensità e
singolarità delle sue odi, come le celeberrime ''All'Autunno'',
''A un Usignolo'' e anche ''A un vaso greco'' inesistente; del
resto a una critica dell'amico Byron rispose ''lui descrive quel
che vede, io quel che immagino''. La Fusini trova che quel che
lega tutto è l'irrequietezza del poeta, profondamente romantico,
e quel suo disincanto nel sentire la rottura e la perdita della
genuinità e l'armonia del mondo classico, ferita che si medica
con la pratica della bellezza (''Una cosa bella è una gioia per
sempre'' è il primo verso di ''Endymion''), la cui idea è nella
''Ode a un vaso greco'' strettamente associata a quella di
verità.
Questo senza dimenticare come Keats si forma filosoficamente
frequentando Leigh Hunt, e la redazione del suo periodico
radicale ''The examiner'', dove tra l'altro scopre la cultura e
la poesia greca e impara da affidarsi alla lucidità della
ragione, tanto che ''Endymion'' verrà definito da Wordsworth
''un bel pezzo di paganesimo''. Quindi un materialista, almeno
nel senso in cui possiamo dirlo anche di Leopardi, con un forte
senso etico (''chi è creativo deve creare sé stesso'') che
avverte però così sempre una sorta di assenza, di vuoto
nostalgico e malinconico, al fondo quasi un dolore, anche nei
momenti in cui il suo sensibilissimo sentire appare più estatico
e risolto. E' forse quella ''capacità negativa'' attraverso cui,
asserisce, il poeta osserva e sente la realtà.
Aldilà delle scritture programmate e progettate appaiono
quelle più istintive e profonde a lasciare il segno, da quel
manifesto del romanticismo che è considerato ''Sonno e poesia''
ai i versi della ''Belle dame sans merci'' che ne fanno il
maestro osannato dai preraffaeliti, dall'ode ''A un usignolo''
il cui canto lo rende ''immortale'', l'arte e la bellezza sole
possono superare la morte, la caducità della vita umana, sino
all'ode ''All'Autunno'' in cui, ormai preda della malattia, di
cui con i suoi rudimenti medici riconosce la gravità, c'è un
certa accettazione della propria fine cantando il rimpianto
della primavera dopo la quale ''l'estate ha colmato oltre l'orlo
gli alveoli''. E per la sua tomba lasciò questa iscrizione:
Questa tomba contiene i resti mortali di un giovane poeta
inglese che, sul letto di morte, nell'amarezza del suo cuore, di
fronte al potere maligno dei suoi nemici, volle che fossero
incise queste parole sulla sua lapide: 'Qui giace un uomo il cui
nome fu scritto sull'acqua'''.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA